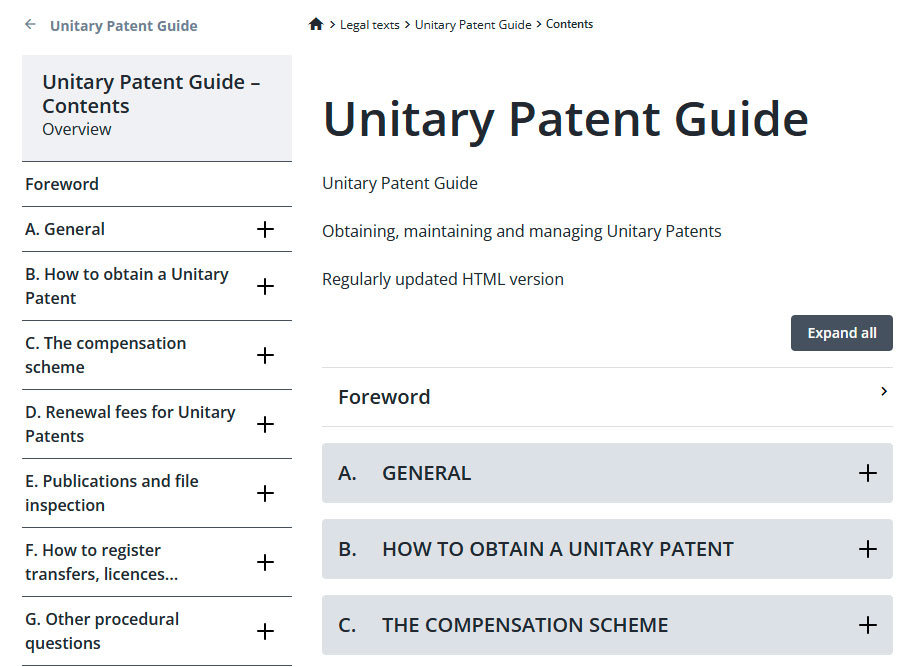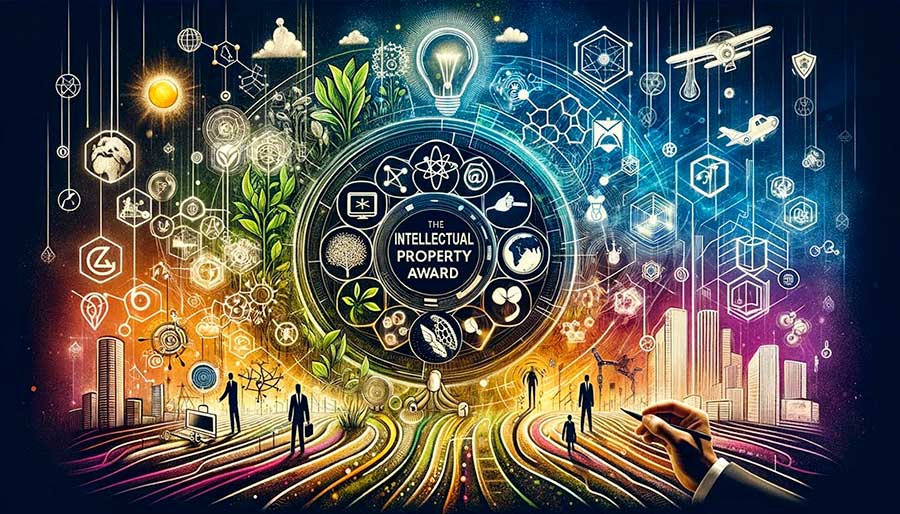Brevetti farmaceutici e il patto faustiano dell’Europa moderna
Possiamo davvero accettare che la salute, bisogno primario e diritto naturale dell’uomo, sia vincolata a un numero, a una scadenza, a una strategia di lancio sui mercati? È questo l’interrogativo cruciale che accompagna la riforma della legislazione farmaceutica europea: un apparato normativo tanto vasto quanto rivelatore della nostra decadenza.
Come Faust nell’opera di Goethe, l’Europa ha stretto un patto con il diavolo della modernità: la conoscenza scientifica in cambio del dominio sulla vita. Ma come ogni patto mefistofelico, anche questo esige un prezzo. E il prezzo è la subordinazione della salute al brevetto, cioè al monopolio temporaneo concesso per legge al fine di permetterne lo sfruttamento economico.
Indice dell'articolo
Cosa prevede la riforma dei brevetti farmaceutici in Europa
La riforma in discussione, la più ampia degli ultimi vent’anni, prevede una riscrittura dell’intero sistema d'incentivazione brevettuale. Il fulcro si chiama Regulatory Data Protection (RDP): sei anni di esclusività sui dati, estendibili a otto solo se il farmaco sarà reso disponibile in almeno 25 Paesi dell’Unione entro due anni dalla registrazione.
Una clausola apparentemente tecnica, ma già oggi svuotata di senso perché il Consiglio dell’Unione Europea ha bocciato l’impianto “modulare” della Commissione rifiutando l’idea di partire da sei anni di esclusività dati. La protezione tornerà ad essere lineare: otto anni pieni, senza bonus né penali.
Il segnale è chiaro: più che premiare l’accesso ai farmaci, si sceglie di garantire certezze all’industria consolidando la rendita informativa che è il vero cuore del monopolio farmaceutico. E il “compromesso” invocato dal legislatore si conferma, come da copione, una capitolazione preventiva dello Stato sociale dinanzi ai colossi della chimica.
Ma c’è un ulteriore fattore, più che mai decisivo, che plasma le scelte europee: il peso delle dinamiche internazionali. Negli Stati Uniti — quel faro ambiguo dell’economia globale — non è più soltanto in discussione ma già operativa l’idea di legare i prezzi dei farmaci ai listini di riferimento esteri, inclusi quelli europei. È la clausola di international reference pricing che agita come uno spettro le sale dei consigli di amministrazione delle big pharma.
Il rischio è tangibile: se l’Europa stringesse troppo sui prezzi, le multinazionali vedrebbero crollare i margini nel loro mercato più redditizio, quello americano, dove i governi stanno finalmente iniziando a negoziare i prezzi con le case farmaceutiche, proprio prendendo a modello i costi europei.
Il risultato è una strategia industriale senza più maschere: le aziende ritardano scientificamente i lanci nei Paesi UE; selezionano i mercati; mantengono artificialmente alti i prezzi o, nei casi più estremi, rinunciano a registrare il prodotto laddove il prezzo concordato rischia di fare da benchmark globale al ribasso.
Ecco allora che la clausola dei “25 Paesi”, già fragile, si rivela un nodo geopolitico non più aggrovigliato solo tra logiche europee, ma stretto tra la difesa della marginalità americana, la minaccia di un’espansione asiatica (Cina inclusa) e il sacrificio sistematico dell’accesso europeo.
La salute pubblica, ancora una volta, diventa ostaggio di equilibri finanziari che non conoscono frontiere.
Altri capitoli della riforma, anch’essi oggetto di riscrittura, toccano nervi scoperti dell’industria e delle politiche pubbliche:
- I farmaci orfani e pediatrici restano sotto osservazione. La razionalizzazione degli incentivi si traduce ora in criteri più severi: le estensioni di esclusiva saranno concesse solo se il farmaco affronta un bisogno medico realmente insoddisfatto e se la sua efficacia clinica è solidamente dimostrata.
- La protezione di mercato — finora di due anni — viene drasticamente ridotta a uno solo, con possibilità di allungarla a tre solo se il produttore dimostra di aver svolto studi clinici su più Stati membri, aver utilizzato un comparatore adeguato e aver risposto a un bisogno medico concreto. Il mercato, insomma, diventa un’arena in cui chi non soddisfa criteri stringenti paga con la riduzione della rendita temporale.
- L’obbligo di fornitura diventa un’arma nelle mani degli Stati: se un’azienda non garantisce la disponibilità del farmaco in quantità sufficienti entro quattro anni dall’autorizzazione, perde ogni diritto alle estensioni di protezione di mercato su quel territorio. Un’inedita forma di sovranità sanitaria che prova a bilanciare l’asimmetria di potere tra imprese e comunità.
- I voucher trasferibili per gli antibiotici, già controversi, vengono ora limitati: massimo cinque in tutta l’UE (contro i dieci previsti inizialmente) e utilizzabili solo se il farmaco strategico non ha generato più di 490 milioni di euro annui negli anni precedenti. Una toppa tardiva sul rischio che il meccanismo si trasformi in una licenza a stampare denaro.
- La Bolar Exemption si amplia: ora include anche le attività preliminari alle gare d’appalto consentendo ai produttori di generici di prepararsi ancora più in anticipo senza temere cause per violazione di brevetto.
Dietro ogni articolo ed ogni comma si intravede l’ossessione per il “mercato unico”, la mitologia dell’innovazione, l’aritmetica dell’interesse.
E se l’aritmetica dell’interesse detta il contenuto, il teatro politico ne stabilisce i tempi e le forme. A guidare questa danza diplomatica è stata, in prima battuta, la Polonia che ha strappato in extremis un accordo sul mandato negoziale prima di cedere il testimone. Ora tocca alla Danimarca il compito di condurre il trilogo, quel rito opaco e informale in cui Parlamento, Consiglio e Commissione negoziano a porte chiuse la versione finale delle leggi europee.
Un negoziato iniziato ufficialmente nel giugno 2025, già circondato dall’urgenza e dal sospetto che i sei mesi della presidenza danese non basteranno a domare il mostro normativo che si aggira sul tavolo: oltre 700 pagine fitte di commi, deroghe, rinvii e clausole sospensive.
Ma non è un ruolo neutrale, né innocuo. La Danimarca si muove in equilibrio precario tra il dovere istituzionale di mediazione e le pressioni di un’industria farmaceutica nazionale potente, ben radicata, che ha tutto l’interesse a spingere per un quadro favorevole ai brevetti.
Nel frattempo, le fratture si fanno visibili e, giorno dopo giorno, più profonde. Il Parlamento Europeo spinge su un fronte più sociale con più garanzie sull’accesso ai farmaci e meno privilegi sulle esclusive. Il Consiglio — guidato dai governi più esposti agli interessi industriali — tiene duro su un modello che protegga la competitività europea, già percepita come minacciata dall’espansione asiatica e dalla stretta americana sui prezzi.
Il rischio non è più una prospettiva sul futuro: è qui, adesso.
Il trilogo si è aperto sotto la guida della Danimarca ma è già chiaro a tutti che il negoziato rischia di trascinarsi ben oltre il semestre danese. E così il dossier finirà nelle mani dell’Ungheria che da luglio assumerà la presidenza di turno del Consiglio UE.
Ma l’Ungheria — con il suo modello sovranista, la sua dichiarata insofferenza verso le logiche comunitarie e il suo disincanto verso le mediazioni multilaterali — non promette alcuna garanzia.
A Bruxelles si sussurra apertamente che, più che governare il compromesso, il governo ungherese rischia di trasformare la riforma nel detonatore finale di un fallimento politico annunciato. Un passaggio di testimone che ormai non è più un’eventualità ma un fatto: la staffetta verso l’impasse è già in corso.
E così la riforma che doveva accelerare l’accesso ai farmaci rischia, paradossalmente, d’impantanarsi nei tempi lenti e deformi della burocrazia comunitaria, vittima perfetta di quel patto mefistofelico tra diritto, interesse e diplomazia.
Ma al di là delle formule legislative e dei giochi di prestigio normativi, la domanda vera resta sul tavolo: questa riforma migliorerà davvero l’accesso ai farmaci per tutti gli europei? Oppure servirà soltanto a consolidare il potere contrattuale delle multinazionali nei Paesi più ricchi, lasciando gli altri — i cosiddetti “mercati periferici” — nella marginalità?
La nuova clausola sull’obbligo di fornitura sembra, sulla carta, una risposta. Se un’azienda non rende disponibile un farmaco entro quattro anni dall’autorizzazione perderà le estensioni di protezione nel Paese inadempiente. Una leva che gli Stati possono teoricamente usare per contrastare il cronico ritardo dei lanci nei Paesi meno redditizi.
Ma basterà?
Davvero una multinazionale teme di perdere una protezione aggiuntiva in Romania o in Croazia, se il vero mercato resta la Germania, la Francia o l’Olanda?
Il rischio è che la leva del brevetto, anziché essere uno strumento per accelerare l’accesso, resti un dispositivo di selezione geografica del diritto alla cura. Una mappa dell’Europa in cui la velocità con cui arriva il farmaco non sarà più dettata dall’urgenza sanitaria, ma dalla capacità di un Paese di pagare un prezzo che non metta in discussione il margine globale dell’industria, soprattutto rispetto agli Stati Uniti.
In fondo è il paradosso che questa riforma non ha mai osato sciogliere: se la salute è un diritto, perché continuiamo a trattarla come una commodity negoziabile?
Chi comanda davvero nella riforma farmaceutica UE: il potere di EFPIA
Non è un mistero chi eserciti l’influenza più grande sulla riforma. Nathalie Moll, direttrice generale della European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), parla a nome di quasi duemila aziende. La sua biografia è esemplare: studi eccellenti, multilinguismo, esperienze internazionali. Ma ciò che conta è la sua funzione: portavoce di un mondo che misura la malattia in termini di ROI, lo spietato "ritorno sugli investimenti" che trasforma la malattia in margine di profitto.
In una dichiarazione recente rilasciata dopo l’approvazione della posizione del Consiglio UE (giugno 2025), Moll ha ribadito che «se l’Europa continuerà a indebolire i diritti di esclusiva, la ricerca clinica si sposterà inevitabilmente altrove: negli Stati Uniti, in Cina, o nei Paesi che meglio comprendono il valore dell’innovazione». Ebbene, non è forse già questa affermazione una forma di minaccia? Non è forse il modo in cui il potere oggi si esercita, non più attraverso la legge, ma con l’annuncio di una fuga di capitali, di una delocalizzazione della ricerca, di un’erosione della competitività?
Oppure, più semplicemente, Moll si pone come portavoce autentica di un modello economico che non conosce altra grammatica se non quella del profitto.
E la posizione istituzionale non è meno rivelatrice: il comunicato ufficiale del Consiglio Europeo, pur proclamando l’obiettivo di “garantire un miglior accesso ai medicinali mantenendo la competitività dell’industria farmaceutica europea”, conferma che la priorità resta la tenuta del sistema industriale, più che la riduzione delle diseguaglianze tra Stati membri.
La salute resta, ancora una volta, materia prima da processare nelle filiere del mercato.
In questo contesto il brevetto non è più uno strumento d'incentivo, ma una leva geopolitica. E l’Unione Europea, che si voleva “casa dei popoli”, si scopre docile serva dei giganti farmaceutici, ostaggio consapevole della sua stessa dipendenza industriale.
Quando il brevetto diventa il confine tra chi vive e chi muore
Il brevetto in origine nasceva come compromesso: riconoscimento temporaneo di un diritto esclusivo in cambio della futura disponibilità del bene. Ma oggi è degenerato in meccanismo di controllo: attraverso i brevetti si determinano i tempi del mercato, si ritardano i generici, si selezionano i territori dove l’accesso è economicamente “conveniente”.
L’Europa, che pure ha inventato l’idea moderna di solidarietà, si trova ora stretta tra l’ideale e la contabilità e pare voler scegliere la seconda. Come Faust, sedotta dalla potenza della formula, dimentica l’anima.
«Ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo se vuoi possederlo davvero.» scriveva Goethe. Ecco la nostra sfida: riconquistare la sovranità sulla cura, riaffermare che la medicina non è solo scienza applicata ma gesto di civiltà.
L’Europa che sceglie tra la salute dei popoli e il potere dei brevetti
Forse verrà il giorno in cui i popoli europei chiederanno conto ai loro rappresentanti. Chiederanno perché la molecola salvavita arrivava prima in Canada che in Croazia, perché il generico costava ancora dieci volte il prezzo di produzione, perché il farmaco pediatrico era “non prioritario” per ragioni di business.
Forse quel giorno le pagine della riforma saranno lette come atti di una tragedia annunciata. Oppure, se saremo capaci di spezzare l’incanto mefistofelico, come il punto di svolta in cui l’Europa tornò a servire la vita e non il suo sfruttamento.
Che ciascuno, allora, ascolti la domanda eterna di Faust: «Che cosa hai dato in cambio del tuo sapere?»
E l’Europa, se vuole sopravvivere alla sua coscienza, dovrà affermare senza più compromessi: la salute non si brevetta.