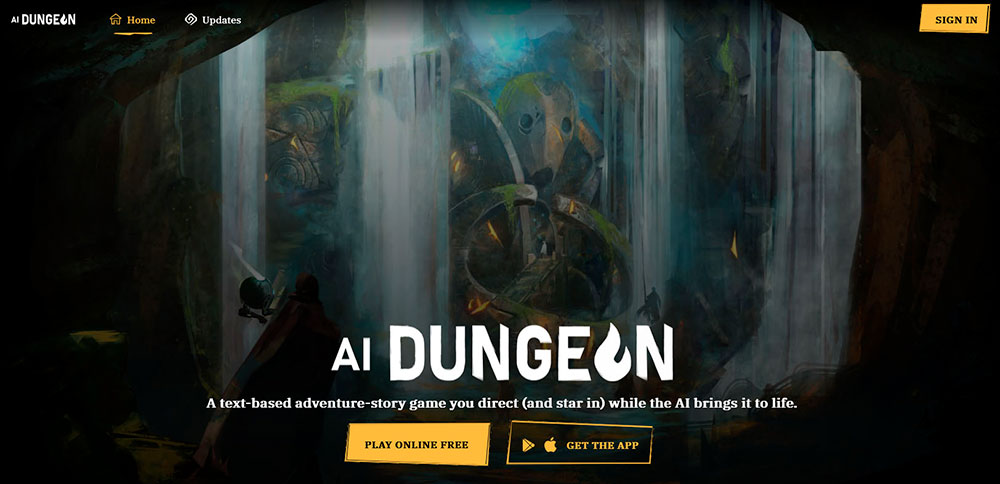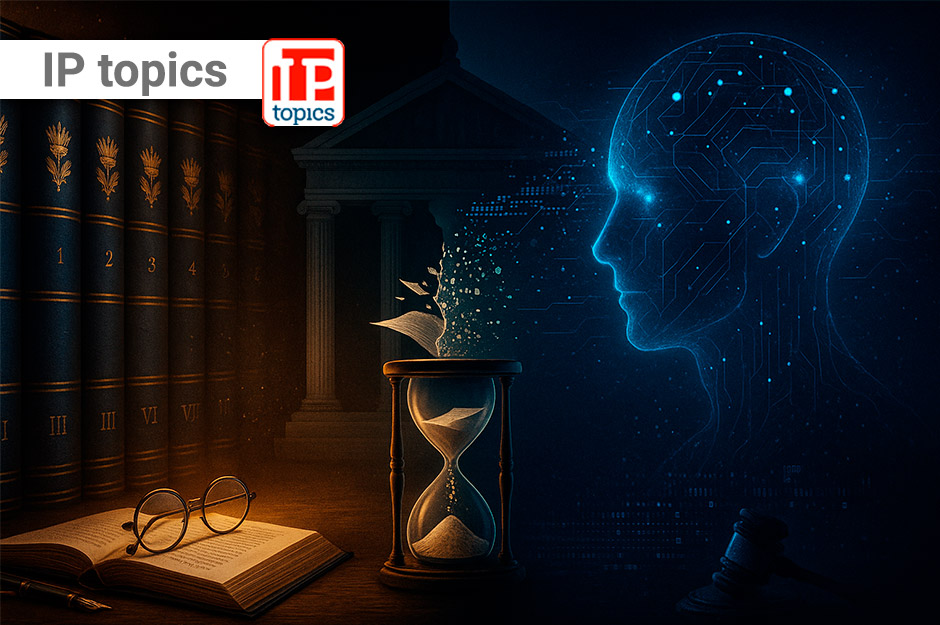
Il tempo rubato della conoscenza nella causa Enciclopedia Britannica contro Perplexity AI
“Viviamo tempi in cui la tecnica non si limita più a servire l’uomo: pretende di sostituirlo.”
(Martin Heidegger, riformulato per il nostro secolo)
L’umanità, stanca di sé e del proprio fardello di sapere, sembra aver ceduto il testimone della memoria a entità impersonali incapaci di coscienza ma dotate di una capacità illimitata di accumulo, riformulazione e sintesi: le macchine del calcolo, le intelligenze artificiali.
È in questo scenario, denso di inquietudini e prefigurazioni distopiche, che si colloca una vicenda giudiziaria apparentemente circoscritta, ma in verità emblematica del nostro tempo: la causa intentata da Encyclopædia Britannica, Inc. e Merriam-Webster, Inc. contro Perplexity AI, Inc., depositata presso la Corte Distrettuale del Sud di New York il 10 settembre 2025 (United States District Court for the Southern District of New York, docket No. 1:25-cv-07546).
Un processo, si dirà, come altri; eppure è molto di più: è un grido d’allarme lanciato da ciò che resta della cultura scritta contro l’assalto della sintesi automatica, dell’algoritmo che predige e simula, senza più interrogarsi né conoscere, senza citare, ringraziare o compensare. È la voce della civiltà dell’approfondimento, del metodo e della verifica, contro la civiltà della risposta pronta, fluida, persuasiva ma priva di fondamento.
Indice dell'articolo
L’enciclopedia del mondo contro il mondo dell’assenza
Da un lato del ring, la Britannica: nome che evoca una tradizione illustre, monumentale, fiera di un’eredità intellettuale che risale al XVIII secolo quando l’Illuminismo osava classificare tutto lo scibile umano entro le pagine di un’opera enciclopedica. Dal 1768 ad oggi ha accompagnato studenti, studiosi, insegnanti e cittadini comuni lungo il cammino impervio della conoscenza. Accanto ad essa Merriam-Webster, sua consociata che da oltre 180 anni è considerata la fonte lessicografica di riferimento per la lingua inglese americana, editrice del celebre Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, uno dei dizionari più autorevoli d’America e specchio dell’identità nazionale anglofona.
Dall’altro lato Perplexity AI, startup tecnologica con sede a San Francisco, attiva nel settore dell’intelligenza artificiale generativa che promette – e non senza successo – di superare Google, reinventando la ricerca in rete come “risposta” anziché come “percorso”. Non più dieci link blu da consultare e confrontare, ma una risposta diretta, fluida, sintetica, prodotta in tempo reale da un’intelligenza artificiale che legge, assorbe, elabora… e dimentica da dove ha tratto ciò che dice.
“Quando poni una domanda a Perplexity”, si legge nel sito dell’imputata, “essa cerca su Internet in tempo reale, raccoglie intuizioni da fonti di alto livello e le distilla in un riassunto chiaro e conciso, offrendo esattamente ciò di cui hai bisogno, in un tono conversazionale e facile da capire”.
Ma ciò che si distilla, come sapevano bene i filosofi dell’alchimia, comporta una perdita: l’originale si dissolve, il contesto si frantuma, la fonte evapora. Il risultato è un sapere liquido, disincarnato, privo di genealogia.
La sostanza dell’accusa: appropriazione e depredazione
Le due case editrici, rappresentate da uno studio legale tra i più prestigiosi, accusano Perplexity AI di una condotta sistematica e consapevole di appropriazione indebita di contenuti protetti da copyright, nonché di interferenza dolosa con rapporti economici. Le AI di Perplexity – si legge nella denuncia – avrebbero eseguito scraping massivo dei portali britannica.com e merriam-webster.com, ignorando le regole del file robots.txt (progettati per impedire l’accesso automatizzato ai contenuti protetti), eludendo misure tecniche di protezione e facendo uso di questi materiali per addestrare modelli linguistici che poi rispondono agli utenti senza citare le fonti e senza generare traffico verso i siti d’origine.
In altri termini, Perplexity usa i contenuti per cui Britannica e Merriam-Webster pagano autori, linguisti, revisori e tecnici, ma si astiene dal riconoscerne la paternità o dal compensarne l’utilizzo. In questo modo, sostengono i querelanti, non solo viola il diritto d’autore ma interrompe la catena del valore alla base dell’economia editoriale.
Britannica, peraltro, dichiara di aver registrato oltre un miliardo di sessioni nel solo 2024, a conferma del valore economico e culturale dei propri contenuti. Ogni visita sottratta da un answer engine rappresenta un danno, non solo patrimoniale ma esistenziale: è un passo verso la marginalizzazione del sapere umano dietro l’ombra dell’algoritmo.
L’interrogativo di fondo: che ne sarà dell’autore?
Si assiste, dunque, ad una trasformazione epocale del rapporto tra contenuto e contenitore, tra testo e contesto, tra parola e responsabilità. Le AI generative si presentano come oracoli neutri, ma in verità attingono a contenuti umani, selezionati, ponderati, protetti, che poi restituiscono come sintesi impersonali. Il sapere viene consumato senza che nessuno paghi il prezzo della sua produzione.
È un pasto gratis, e ogni economista sa che i pasti gratis non esistono.
Lungi dall’essere meramente tecnica, la questione interroga la sostanza stessa del diritto d’autore che non è solo protezione economica, ma riconoscimento della paternità, rispetto della filiera, garanzia di qualità e autenticità. La conoscenza, sradicata dal suo terreno, si riduce a informazione; l’informazione, privata del suo contesto, scade a intrattenimento.
Nietzsche ammoniva: “Chi scrive aforismi, deve sapere che sarà letto da chi non legge libri”. Oggi potremmo dire: chi genera testi sintetici lo fa per un pubblico che non vuole sapere da dove provengano le parole che legge.
Ma così si distrugge il principio stesso di responsabilità culturale.
L’orlo dell’oblio, la fine della trasmissione
In questa disputa apparentemente giuridica vi è in gioco il futuro stesso della conoscenza trasmessa. Se la civiltà occidentale è – come insegnava Jacob Burckhardt – una trasmissione ordinata del sapere attraverso le generazioni, allora il modello dell’intelligenza artificiale generativa rappresenta una cesura: non più catena di maestri e discepoli, ma architettura di server e risposte.
Non più approfondimento, ma immediatezza.
Non più riflessione, ma resa.
Così si consuma l’eclissi dell’autore, l’annullamento del tempo lungo dell’apprendimento, la dissoluzione del valore culturale in pura prestazione sintattica. È l’Encyclopaedia contro il silenzio dell’engine; è l’ultima trincea della memoria prima che la storia venga sostituita dalla predizione.
Resta da chiedersi: chi parlerà ancora a nome dell’uomo quando a parlare sarà soltanto la macchina?