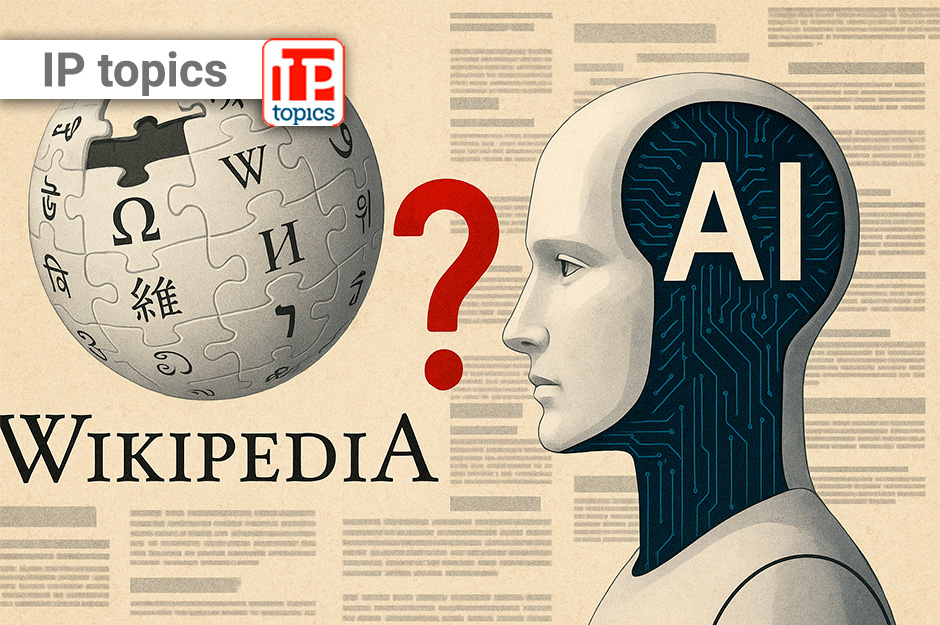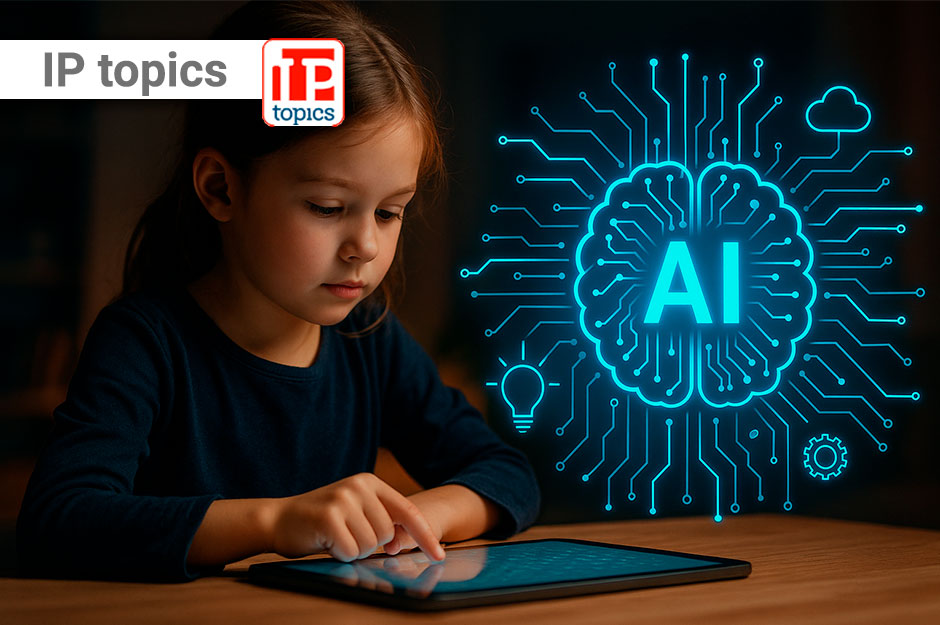Cercando segreti di proprietà intellettuale nei file Epstein
Un’indagine laterale sull’orbita Epstein: tracce di brevetti, marchi e monetizzazione di brand
Chi si occupa a lungo di proprietà intellettuale finisce per vedere il mondo in controluce: dietro alle imprese intravede portafogli di brevetti e dietro i brand marchi registrati; diritti dai confini precisi con una durata definita e un valore economico spesso nascosto.
Con questa lente ho esaminato i file Epstein pubblicati dal Department of Justice (DOJ), cioè il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti, in ottemperanza all’Epstein Files Transparency Act del 2025 (Pub. L. 119–38, 19 novembre 2025).
Non mi interessava la domanda più ovvia, ossia cosa questi documenti potessero aggiungere allo scandalo già noto; piuttosto volevo capire quanto il mondo della proprietà intellettuale incrociasse davvero l’orbita Epstein. In un archivio così vasto emergono tracce di brevetti, marchi, copyright, asset intangibili?
Se sì, in che forme compaiono, chi coinvolgono e in quali passaggi smettono di essere semplice rumore di fondo per diventare elementi operativi?
Per rispondere senza trasformare una coincidenza in una tesi, devo fare un passo indietro e spiegare la scala del materiale analizzato e il metodo di lettura.
Il DOJ parla di “responsive pages”, un’espressione tecnica che indica i documenti ritenuti pertinenti agli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, e la dimensione è, per definizione, fuori scala: complessivamente quasi 3,5 milioni di pagine alle quali si aggiungono anche altri formati (nel rilascio del 30 gennaio 2026, per esempio, sono indicati più di 2.000 video e 180.000 immagini). Un volume simile genera inevitabilmente coincidenze in serie e qualunque termine è destinato a comparire prima o poi. Dunque il vero rischio non consiste nel non trovare nulla ma nel trovare troppo e nel costruire una narrazione che, ad una più profonda analisi, non regge.
A rendere il quadro ancora più delicato c’è un fatto tecnico che il portale ufficiale dichiara in modo esplicito: per limiti di formato e di indicizzazione alcune porzioni dei documenti potrebbero non essere ricercabili in modo affidabile, oppure potrebbero restituire risultati poco attendibili.
Per tali ragioni ho adottato dei criteri restrittivi, convinto che la parte più importante del metodo risieda proprio in ciò che si sceglie di scartare.
La ricerca è partita dai termini più immediati (patents, trademarks, copyright, intellectual property) per poi estendersi al lessico “di servizio” che spesso segnala informazioni attinenti senza nominarle esplicitamente: intellectual assets, trade secrets, know-how, NDA, non-disclosure agreement, licensing, assignment, field of use, background technology, confidential information e relative varianti.
Ho escluso le formule standard che compaiono in header, footer, firme e disclaimer; ho trattenuto solo le occorrenze presenti nel corpo del testo con un contesto leggibile; per termini ambigui come rights ho considerato soltanto i casi accompagnati da indicatori tipici della proprietà intellettuale (licensing, assignment, confidential information, field of use) oppure inseriti in un contesto chiaramente tecnologico.
Ho infine circoscritto l’analisi ai documenti pubblici rilasciati fino a febbraio 2026 concentrandomi su email e allegati testualizzati, circa 500 in tutto.
Non si tratta di un campione “statistico” dell’intero archivio ma del sottoinsieme che, per formato e qualità del testo, consente interrogazioni coerenti e verificabili; il resto, pur essendo talvolta leggibile a occhio umano, non permette lo stesso tipo di ricerca senza introdurre errori.
Dopo ulteriori filtri applicati, sono rimaste una cinquantina di occorrenze classificabili. Per evitare che una parola trovata valga come prova di intenzione, ho ragionato per livelli di evidenza: a fondo scala le formule standard (“all rights reserved” e simili); poi i ritagli e i documenti archiviati che indicano al massimo curiosità o monitoraggio; a salire i passaggi nei quali compaiono discussioni operative su asset e diritti; in cima i documenti transazionali (accordi, NDA, cessioni) e le azioni verificabili.
Una volta costruita questa scala, il punto diventa vedere dove cade davvero il peso del materiale. E qui la distribuzione è netta: le occorrenze “alte” sono poche. Le discussioni operative, infatti, sono rare, appena due o tre su centinaia; i documenti transazionali veri e propri (accordi, NDA, cessioni) sono scarsi; azioni verificabili direttamente attribuibili a Epstein, quali depositi USPTO o contenziosi, non affiorano.
La risposta alle domande iniziali è dunque doppia: sì qualche traccia esiste, ma no, non è la traccia spettacolare che l’immaginazione potrebbe attendersi.
Più che contratti o strategie compiute affiorano tracce minute, ritagli, formule, frammenti di lessico; e proprio perché il bianco predomina, quando compare un punto più scuro lo si nota immediatamente.
Chiarito il perimetro, possiamo guardare al dettaglio e un primo equivoco va subito dissipato: Epstein non era un inventore. Sul fronte dei registri pubblici, una verifica per nome nei database dell’USPTO non restituisce brevetti attribuibili con alta confidenza a Jeffrey Edward Epstein come inventor o assignee; nei file DOJ, inoltre, le occorrenze nominali che compaiono includono anche omonimi con attività brevettuale non collegabile a lui.
Quando brevetti o marchi fanno la loro apparizione, la scena non è mai quella dell’invenzione ma quella della finanza, dell’accesso e della reputazione.
Il caso rilevabile più concreto, e per questo il più istruttivo, è quello di “Mother’s Army”: un progetto legato all’immagine pubblica di Sarah Ferguson, ideato come brand con declinazioni editoriali e televisive rivolte ai bambini. Nei documenti più recenti notiamo email e business plan che prevedevano per Epstein una quota di controllo del 51% nella struttura societaria, con una monetizzazione costruita su leve tipiche della proprietà intellettuale applicata al branding: accordi editoriali, programmi TV per bambini, conferenze retribuite, sfruttamento economico del marchio.
A margine compaiono anche registrazioni di nomi di dominio legati al tema “mother”, le quali rafforzano l’idea del marchio come infrastruttura digitale oltre che narrativa.
Qui sta la differenza rispetto al resto del corpus: non siamo davanti a un termine che compare in un ritaglio, ma a un progetto descritto nei suoi meccanismi.
Dunque la proprietà intellettuale non entra dalla porta dei brevetti, bensì da quella del marchio come asset legato al controllo della struttura societaria e a una filiera di sfruttamento economico e mediatico. Per questo “Mother’s Army” è un indizio più solido: non prova una strategia generale, ma mostra un uso pratico dell’IP nel quale i diritti sul brand e la maggioranza societaria diventano parte della stessa macchina di monetizzazione.
I brevetti, al contrario, restano quasi sempre sullo sfondo. Nei file compaiono soprattutto come materiale di contesto in articoli presenti nel corpus, talvolta inoltrati via email, talvolta semplicemente archiviati senza che sia sempre possibile stabilire chi li abbia selezionati.
Si tratta di storie di contenziosi milionari come quella di un imprenditore del golf sanzionato per avere violato un brevetto su borse, oppure pezzi su lobbying o anticorruzione nei quali viene citato anche l’USPTO (United States Patent and Trademark Office).
In questo genere di testi l’USPTO ricorre spesso per una ragione semplice: è l’ente federale competente per brevetti e marchi, quindi entra naturalmente nel lessico della regolazione e dei controlli. La sua presenza non segnala un’azione, piuttosto inquadra il tipo di ecosistema informativo che veniva letto e archiviato.
In questo paesaggio spiccano anche figure emblematiche dell’innovazione. Dean Kamen, inventore del Segway e titolare di oltre mille brevetti, ringrazia Epstein per visite definite “magiche” a Little St. James. E compare Larry Page, cofondatore di Google, in contesti di pranzi e di possibili viaggi nei Caraibi.
Nei documenti non si discutono in modo esplicito né i loro brevetti né le loro tecnologie: ciò che affiora, semmai, è la prossimità ad un circuito di relazioni ad alta densità “tech”. Proprio per questo la cautela resta indispensabile.
Questi richiami non dimostrano un uso diretto dei brevetti da parte di Epstein, ma sono coerenti con il suo posizionamento in un ambiente nel quale innovazione, contenzioso e regolazione producono continuamente occasioni da osservare e, talvolta, da sfruttare.
Sul fronte dei marchi registrati, al di fuori del caso “Mother’s Army”, il quadro resta per lo più ordinario con vari nomi di compagnie che compaiono in email di routine o in articoli sulla conformità normativa. È il caso per esempio di CheapTickets, un servizio di prenotazioni e biglietteria di viaggio, citato incidentalmente nel materiale d’archivio.
Più contesto che segnali operativi.
Proseguendo nell’analisi, “Copyright” è un termine che compare di frequente, ma rimane decisamente rumore di fondo: per esempio lo si rileva in formule quali “all rights reserved” o in avvisi automatici di piattaforme e banche dati giuridiche (Amazon, LexisNexis).
In mezzo a questo rumore compaiono però alcuni articoli di stampa che trattano il diritto d’autore come oggetto di controversia: uno riguarda lo stato della Georgia dove si è discusso se le annotazioni ufficiali alle leggi statali potessero essere protette da diritto d’autore perché redatte da un editore privato su incarico pubblico, con evidenti ricadute sull’accesso gratuito al testo di legge.
Un altro racconta il caso noto come Prenda Law: uno schema nel quale alcuni avvocati acquisivano diritti su film pornografici, li facevano circolare su reti di file sharing e poi minacciavano azioni legali contro le persone accusate di aver scaricato o condiviso quei file, chiedendo loro pagamenti per chiudere la controversia prima del giudizio.
Tuttavia sono articoli presenti nel corpus, non documenti operativi riconducibili a Epstein e servono a fotografare un contesto nel quale il copyright può diventare una leva di pressione economica; vanno quindi letti per ciò che sono: informazione di fondo, non prova d’intenzioni.
Fin qui siamo rimasti nella zona bassa della scala; ora vale la pena salire verso i pochi passaggi in cui l’IP non è solo contesto. Tra questi le occorrenze di “intellectual assets” sono rare e, proprio per questo, particolarmente significative: nel 2013 Epstein scrive a Peter Mandelson suggerendo di monetizzare asset intangibili governativi non sfruttati quali brevetti, know-how e risultati della ricerca pubblica, facendoli passare per canali universitari e reinvestendone i proventi in nuova ricerca o iniziative pubbliche.
È uno dei pochi passaggi davvero “operativi” nel senso minimo del termine perché contiene un ragionamento rivolto a un interlocutore e non un articolo archiviato; rimanda inoltre, in modo abbastanza trasparente, a trasferimento tecnologico e valorizzazione di beni intangibili.
A questo livello compaiono anche elementi che non sono “proprietà intellettuale” in senso stretto, ma aiutano a capire il contesto istituzionale nel quale Epstein si muoveva. È il caso di “Project Jeep”, nome in codice di una revisione interna condotta da JPMorgan nel 2019 sul proprio rapporto con Epstein, richiamata poi nelle richieste e nelle iniziative di controllo del Senate Finance Committee del Senato degli Stati Uniti. Non è un tassello di IP diretto, serve piuttosto a mostrare come una grande banca inquadrasse il “rischio Epstein” e come certe relazioni venissero trattate in termini di conformità normativa e controlli interni.
Nasce qui una tentazione interpretativa in parte legittima: quando le relazioni toccano settori a duplice uso (biotech, sorveglianza, infrastrutture digitali) e si muovono in circuiti transnazionali tra fondazioni, giurisdizioni offshore e partnership pubblico-private, la proprietà intellettuale può assumere anche una dimensione geopolitica. Nei materiali pubblici, tuttavia, manca la documentazione contrattuale che trasformerebbe questa suggestione in una pista.
Accanto a questi elementi più “istituzionali”, nei file compaiono anche dettagli minori che non provano nulla ma aiutano a delineare l’ambiente. Per esempio c’è una fotografia che mostra libri dedicati al cervello umano nella biblioteca di Epstein e compare una proposta del 2010 relativa a ricerche neuroscientifiche presso l’Università della California a San Diego (UC San Diego). In questa, Epstein risulta tra i destinatari o tra i soggetti coinvolti nella valutazione.
In un’altra traccia documentale, datata 2011, il suo indirizzo risulta incluso in una lista email riservata che comprende anche fondatori o dirigenti apicali di aziende quali Amazon, Google, Facebook, Microsoft e Tesla.
Sono segnali di un’orbita scientifica e tecnologica nella quale la proprietà intellettuale è moneta corrente anche quando non viene nominata. Ma, per come compaiono nei materiali pubblici, restano elementi di contesto e non dimostrano licenze, cessioni o titolarità di brevetti e marchi, né investimenti strutturati in asset intangibili.
Le persone citate hanno poi preso le distanze da Epstein, spesso in modo esplicito. Dean Kamen ha sospeso incarichi in consigli di amministrazione, ha collaborato con verifiche e indagini e ha dichiarato di non aver avuto conoscenza delle “azioni orribili” attribuite a Epstein. Larry Page e Google hanno chiarito pubblicamente che non vi erano legami ufficiali, né accuse a suo carico. Peter Mandelson ha espresso rammarico profondo, definendo Epstein un abile impostore e riferendo di esserne stato ingannato; Bill Gates ha parlato di un errore di valutazione legato alla filantropia e ha negato qualsiasi illecito.
Questo passaggio serve a evitare un cortocircuito tipico degli archivi: un nome che compare in un documento segnala un contatto o una contiguità, non una partecipazione e, ancora meno, una condivisione di scopi.
Avviandoci alla fine dobbiamo tirare le dovute conclusioni: in un archivio di queste dimensioni le tracce di proprietà intellettuale esistono, ma non nel modo “spettacolare” che un lettore potrebbe immaginare. La forma più comune è quella del contesto dato da formule standard, avvisi automatici, articoli archiviati o inoltrati, riferimenti a contenziosi, citazioni di istituzioni come l’USPTO. In altre parole l’IP compare spesso come lessico di accompagnamento, non come oggetto di una strategia documentata.
Quando si guarda a chi sia coinvolto, la risposta è altrettanto sobria: più che inventori “legati” a Epstein, compaiono ambienti e circuiti (tecnologia, finanza, università) nei quali brevetti, marchi e diritti intangibili sono parte del paesaggio.
I nomi che affiorano (innovatori, imprenditori, figure pubbliche) indicano accesso e contiguità, non necessariamente operatività ed è per questo che vanno letti con prudenza: comparire non significa partecipare, né condividere scopi.
Il punto decisivo è dato dall’ultima domanda posta inizialmente: quando l’IP diventa operativa?
Devo ammetterlo: nei materiali pubblici questo salto si vede raramente. Il caso più istruttivo è quello di “Mother’s Army” dove il marchio è trattato come asset: controllo societario, sfruttamento editoriale e televisivo, infrastruttura digitale. È un esempio in cui la proprietà intellettuale non è soltanto citata ma entra nella meccanica del progetto.
Un altro passaggio relativamente “alto” è la email del 2013 sugli “intellectual assets” che rimanda a logiche di trasferimento tecnologico e valorizzazione di diritti.
Per il resto ciò che manca è quasi più eloquente di ciò che c’è: nei documenti pubblici non compaiono in modo sistematico licenze, cessioni, royalty, NDA strutturati, depositi o contenziosi riconducibili a Epstein. La risposta finale, quindi, è questa: sì, il mondo IP incrocia l’orbita Epstein ma nei materiali disponibili lo fa soprattutto come sfondo informativo e linguaggio di un ecosistema.
Per ora è così; il resto, se mai verrà, sarà scritto nei prossimi rilasci di documenti pubblici che leggerò con la stessa lente e lo stesso accurato metodo.
Riferimenti essenziali
- U.S. Department of Justice (DOJ, Department of Justice), “Epstein Library” (portale ufficiale; indicazione in pagina: “Last Updated: February 13, 2026”). https://www.justice.gov/epstein
- U.S. Department of Justice (DOJ), comunicato stampa “Department of Justice Publishes 3.5 Million Responsive Pages in Compliance with the Epstein Files Transparency Act” (30 gennaio 2026). https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-publishes-35-million-responsive-pages-compliance-epstein-files
- Congress.gov (U.S. Congress), testo dell’“Epstein Files Transparency Act” (H.R. 4405; Public Law 119–38, 19 novembre 2025). https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/4405/text
- GovInfo (U.S. Government Publishing Office), “Public Law 119–38 (Epstein Files Transparency Act)” (versione ufficiale della legge, HTML). https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-119publ38/html/PLAW-119publ38.htm
- U.S. Senate Committee on Finance (Sen. Ron Wyden, Ranking Member), comunicato/nota ufficiale con riferimenti a “Project Jeep”: “With JPMorgan Chase Dodging Epstein Inquiry, Wyden Investigation Drills Down on Bank Executives’ Unexplained Conduct”. https://www.finance.senate.gov/ranking-members-news/with-jpmorgan-chase-dodging-epstein-inquiry-wyden-investigation-drills-down-on-bank-executives-unexplained-conduct
- Sky News, “What do the Epstein files say about Sarah Ferguson?” (ricostruzione su “Mother’s Army”, quota di controllo e sfruttamento del marchio). https://news.sky.com/story/what-do-the-epstein-files-say-about-sarah-ferguson-13505210
- DomainIncite, “Epstein bought ‘mother’ domains for Fergie while serving time” (registrazioni di nomi di dominio collegati all’ecosistema “Mother’s Army”). https://domainincite.com/31527-epstein-bought-mother-domains-for-fergie-while-serving-time